Ve la ricordate la prima parte di “Bambi”? Sto parlando di quella parte che si conclude con quella scena terrificante in cui arrivano i cacciatori e sparano alla madre.
Ve la ricordate adesso? No? Tranquilli, ci penso io a rinfrescarvi la memoria:
Vi ho fatto scendere la lacrimuccia, vero? Vi ho rovinato la giornata, vero?
Ma perché, quando guardiamo questa scena-tra l’altro costruita in modo perfetto. Ci sarebbe da parlarne per ore della neve e di quella figura del padre che è un’ombra senza volto, fredda e incapace di aiutare suo figlio-e se fossi un Grodal, un Plantiga, un Frijda o un Gallese di un certo livello, inizierei a parlare di embodied simulation, di empaty e symphaty, di sentimentalismo e di neuroni specchio.
Ma io non sono un Grodal, un Plantiga, un Frijda o un Gallese di un certo livello, e vi dirò che, per me, il momento ci colpisce perché segna un passaggio: Bambi, improvvisamente, diventa grande e perde dei punti di riferimento. Che poi il tutto sia inserito in una storiella classica e tipicamente americana trita e ritrita (gli amici che diventano una seconda famiglia e ci aiutano a fare pace con la nostra famiglia/ condizione d’origine) rimane sempre il punto dolente di molti film anche della Disney.
Continuando il discorso, credo che Bambi sia stato un po’ il trauma di tutti.
Un altro trauma indelebile, almeno, per me, è stato il film Germania Anno Zero di Rossellini.
Cosa mi ha sconvolto di quel film? TUTTO!
Avanti, non fate gli eroi: un film in cui c’è un bambino che guarda la sua città distrutta e poi, disperato, decide di uccidersi è un colpo al cuore.
Ma cosa hanno in comune un film come Bambi ed uno come Germania Anno Zero?
Credo che, nel mio cervello bacato, le due pellicole-una del 1942 e l’altra del ’48-, sono collegate per il tema dell’estetizzazione del trauma: nel primo, il trauma è praticamente l’incipit della storia; nel secondo è la presa di coscienza che abbiamo una ferita che non riusciremo mai a sanare e che, in qualche modo, è tutta colpa nostra.
Ecco, se per entrambi i film potremmo parlare per ore-non lo faremo, tranquilli-, quello che mi interessa è quello che manca: il presente!
Se in Bambi c’è un geniale salto temporale, in Anno Zero manca tutto il prima.
I motivi sono tanti: l’economia del racconto-un processo che, al cinema, potrebbe essere descritto così: “nun ce stanno i sordi pe o sbarco in Normandia. Cambia a sceneggiatura e togli tutte e scene de guera”-; il focus è concentrato su altre cose e poi perché, ammettiamolo, di cosa succede durante qualcosa, a noi non ce frega una beata fava. O no?
Beh, ci sono autori che, invece, di quello che succede durante se ne fregano eccome e riescono a tirare fuori libri meravigliosi dalle più disparate situazioni.
Non ci credete?
Vi farò ricredere:
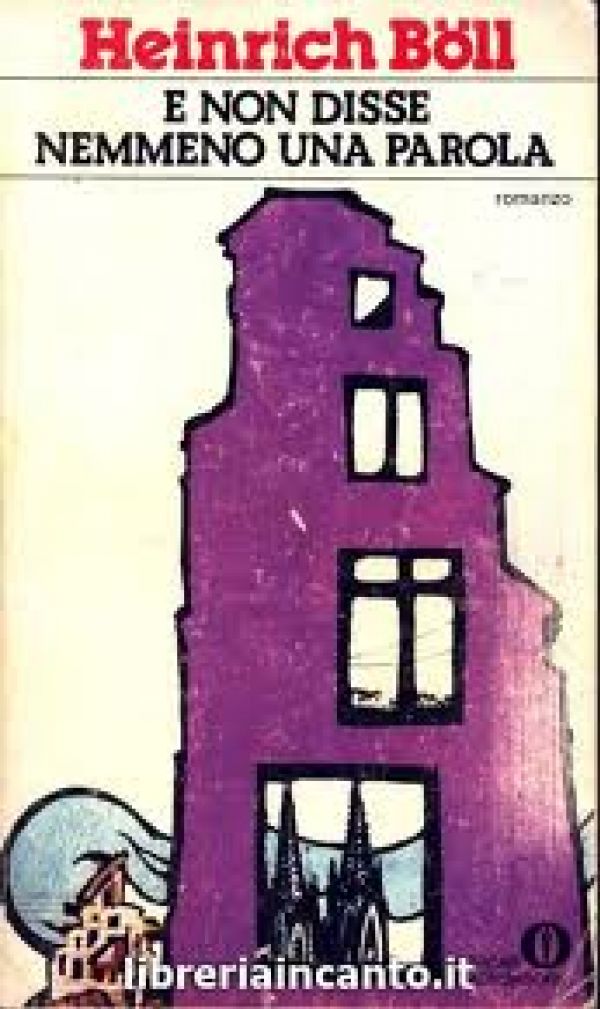
TITOLO: “E non disse nemmeno una parola”
TITOLO ORIGINALE: Und sagte kein einziges Wort
AUTORE: Heinrich Böll
ANNO PRIMA PUBBLICAZIONE: 1953
TRAMA:
Germania, primissimo dopo guerra. Dopo la sconfitta della seconda guerra mondiale il paese è distrutto e non si vede nessuna possibilità di futuro o riscatto. Fred e Käte Bogner sono una coppia. Vivono separati. Hanno due figli. Le speranze di ricostruire il loro matrimonio sembrano essere state spaccate dai bombardamenti: lei vive con i figli in un orrendo monolocale, lui vivacchia, beve, non riesce a trovare lavoro. Il romanzo narra di un loro incontro in uno squallido hotel di una squallida città distrutta dalla guerra
Detta in questi termini, la trama di questo meraviglioso romanzo-forse il più sconosciuto, il meno letto di Heinrich Böll-, può sembrare banalotta e inconcludente ed è qui che tutti quanti, leggendo la quarta di copertina, ci sbagliamo: “E non disse nemmeno una parola” è un ritratto realistico, crudele e meraviglioso di una terra, di un popolo e di un sentimento-quello dell’amore-che spesso si è perso.
Chi è avvezzo alla letteratura di Böll lo sa: l’autore parta da qualcosa di banale, una situazione “normale” per parlare di altro, di tutto, dei massimi sistemi.
Procedendo con ordine, la narrazione fa entrare immediatamente il lettore nella storia: tutto è raccontato in prima persona e da due voci-quella di Käte e quella di Fred-che si avvicendano, capitolo dopo capitolo, nel racconto della loro quotidianità irreale: lei vive in uno sporco e misero monolocale i cui affittuari sono una famiglia di ricchi che abita nell’appartamento di fianco ed è costretta letteralmente a fare i debiti per potersi permettere una babysitter per i fugaci, quasi scabrosi, incontri che si concede con il marito. La descrizione dei suoi vicini di casa, dei suoi padroni è spietata: una coppia di vecchi e ricchi borghesi che, pensando di essere a riparo in casa loro (in realtà le pareti che separano le due case sono così sottili, che si sente ogni minimo rumore) sparano giudizi cattivi sul mondo e sugli altri. La particolarità è che, spesso, gli attacchi sono rivolti alla servitù e a Käte che, nel suo contegno silenzioso, sopporta tutto.
Chiaro il riferimento che l’autore fa nei confronti della borghesia che non si arrende alla sua disfatta, al decadimento di quello stato sociale e di quei titoli nobiliari che, in qualche misura, erano un gioiello da mostrare al mondo.
La vita di Fred è molto più libera ma, allo stesso tempo, più gretta: si muove nei bassifondi loschi di una città distrutta, privata dell’anima e passa il tempo ad ubriacarsi e a cercare i soldi per la notte con sua moglie, i soldi per le sigarette, per l’uscita che vogliono fare insieme, per l’hotel e per la cena.
Una civiltà dimenticata, un mondo che deve essere tenuto nascosto ma che, sembra suggerirci l’autore-grande oppositore del regime fascista e pacifista-che le vere vittime, senza nulla togliere ai milioni di ebrei e di soldati sacrificati per una guerra sbagliata, sono proprio loro: i veri cittadini, quelli che, di diventare degli eroi, non ci hanno mai pensato
Continuando con la narrazione, Käte riesce a trovare una babysitter per la notte e lei gli chiede se può portare i figli al luna park insieme al suo ragazzo, lei acconsente, si fa bella ed esce, arriva ad una chiesa e vuole confessarsi. Qui arriva un’altro dei temi cari all’autore: la religione.
La chiesa è descritta come un luogo oscuro, rabbrecciato, con i muri dipinti e i crocifissi in acciaio. Il prete che celebra la funzione sembra fare più attenzione ai soldi che servono per ricostruire la chiesa, che alle verità del Vangelo. Dopo la funzione lei decide di confessarsi perché si sente in colpa: passare una notte con suo marito che non vive con lei le sembra un atto iniquo, un peccato. Il prete non sa cosa rispondere e la assolve per un peccato che non ha commesso per il semplice motivo che, un peccato, non esiste.
In questa scena è evidente la sua critica. La chiesa distrutta e mai ricostruita sono chiaramente una critica verso la strumentalizzazione di un’ideale-in questa fattispecie quello nazista-che, morto, viene tenuto in vita soltanto dalla forza dell’abitudine, e dell’incapacità di quella che Nietzsche definirebbe “la religione paolina” a capire i problemi reali, concreti, della gente in carne ed ossa (perché è peccato fare sesso con il proprio marito?).
Nel corso della loro strana avventura, i due personaggi si imbattono nello stesso negozio/panificio/latteria in cui incontriamo due personaggi chiave: la figlia e il figlio del padrone. La figlia è un personaggio angelico, sorridente, solare, che ridà speranza, infonde tranquillità e si offre, praticamente, di fare credito ai personaggi. Suo fratello è un ritardato che sta seduto vicino all’ingresso del negozio e mangia una brioche. Entrambi i personaggi rappresentano, in qualche modo, il mondo ideale: la figlia del proprietario quella di uno Stato umano, attento ai bisogni degli altri e del fratello.
Ecco, il fratello potrebbe sembrare una cosa didascalica ma perché? In fondo la Germania non ha avuto un sistema che prendeva tutti i gay, i ritardati, i malati mentali, gli ebrei, i portatori di handicap e li faceva morire? E cosa c’è di più bello di capire che possiamo andare tutti d’accordo senza discriminarci?
La scena dell’appuntamento della coppia è la più toccante del libro: vanno insieme al lunapark e, quando vedono i figli che sono usciti e si divertono con la coppia che gli fa da babysitter, si nascondono. Cosa ci dice questa scena? Diverse cose importanti: i due vanno al lunapark nonostante abbiano passato da anni l’età per farlo ed è un chiaro riferimento alla situazione della guerra che ha letteralmente rubato la vita delle persone; i due scappano di fronte alla coppia e ai propri figli e la coppia e più giovane e figli sono felici e, inevitabilmente, immedesimandoci nei personaggi, siamo portati a pensare che se non ci fosse stata la guerra, se ci fosse stata un’eterna giovinezza, una spensieratezza che ci avesse e li avesse cullati ancora per qualche anno, forse avrebbero avuto un futuro migliore; e poi il lunapark è un mondo di finzione, un mondo dove tutto e bello, tutto è di facciata. Anche questa immagine potrebbe essere collegata all’assurdità dei vicini di casa di lei e del nazismo in generale: tutto è bello, ma tutto quello che è bello è anche finto, la vita vera è quella della camera d’albergo sporca e con le pareti grige in cui i due non consumano l’atto sessuale ma parlano, parlano della loro fragilità e delle loro debolezze e capiscono che, l’unica scelta logica, sarebbe di finirla, di lasciarsi per sempre e di smetterla di provarci.
Già, l’ideale sarebbe di smetterla ma non lo fanno e il bel finale in sospeso, aperto, forse ci vuole dire proprio questo: che l’amore è l’unico esistenzialismo davvero umanista per cui vale la pena di non lasciar perdere
